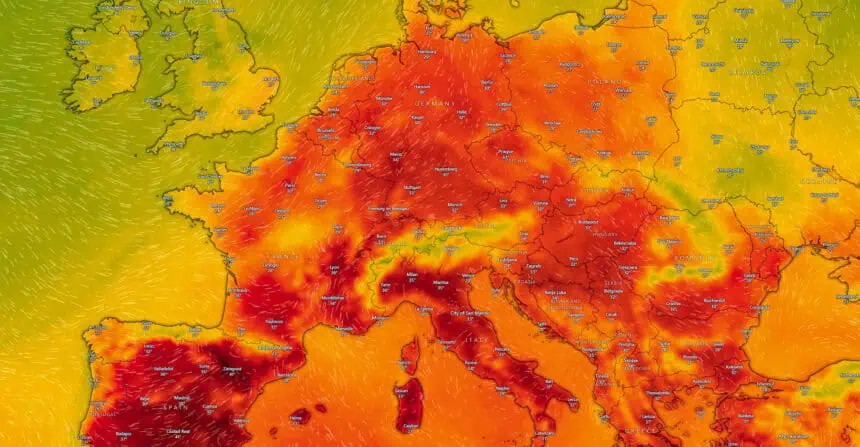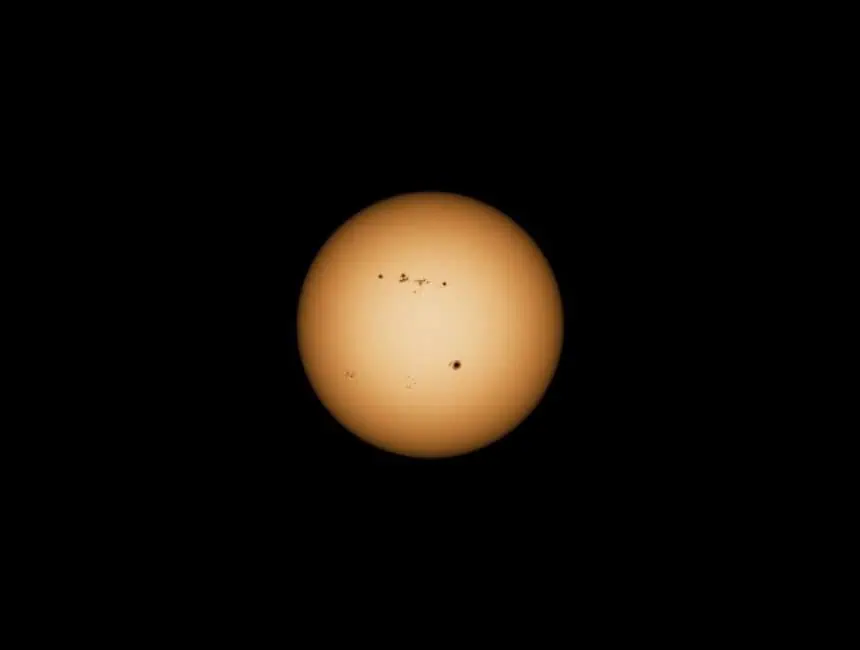Quando la bellezza diventa un criterio di salvezza
Nel mondo della conservazione ambientale, esiste un pregiudizio radicato e largamente ignorato: il cosiddetto “privilegio della bellezza”. Questo fenomeno influenza in maniera profonda sia le scelte del pubblico, che tende a donare fondi solo alle specie più affascinanti, sia le decisioni degli scienziati, che dedicano attenzione sproporzionata agli animali più vistosi, a scapito di quelli meno attraenti ma spesso più vulnerabili.
Elefanti, tigri e panda continuano a ricevere la maggior parte delle donazioni globali per la conservazione, mentre roditori poco appariscenti, anfibi poco conosciuti e alghe invisibili all’opinione pubblica ricevono solo una minima parte delle risorse, pur rientrando tra le specie più minacciate di estinzione.
Il bias anche nella ricerca scientifica
Uno studio pubblicato ad aprile 2025 ha dimostrato che anche il mondo accademico non è immune da questo pregiudizio. Analizzando oltre 27.000 articoli scientifici pubblicati tra il 1965 e il 2020 su uccelli canori del Nord America, i ricercatori hanno scoperto che le specie più attraenti visivamente venivano studiate tre volte più spesso rispetto a quelle meno appariscenti.
Per valutare l’estetica, gli autori hanno sviluppato un sistema che includeva colore del piumaggio, iridescenza, leggerezza visiva e massa corporea. I beccofrusoni boreali e le rondini degli alberi, con le loro piume eleganti e colori brillanti, erano in cima alla lista. In fondo si trovavano invece il rondone ciminiero e il rondone nero, entrambi grigi, scuri e simili tra loro. Non solo l’estetica, ma anche la facilità di accesso geografico ha avuto un impatto: la maggior parte degli studi si è concentrata su uccelli vicini a università e centri urbani.
Conseguenze gravi per la sopravvivenza delle specie ignorate
L’impatto di questo pregiudizio visivo va ben oltre la semplice rappresentazione nei libri o nei documentari: può compromettere gravemente la sopravvivenza di intere specie. Come sottolineato dai ricercatori, se non conosciamo lo stato di salute di una specie, non possiamo nemmeno proteggerla in modo efficace.
Il problema sistemico dei finanziamenti alla conservazione
Uno studio pubblicato a febbraio 2025 ha analizzato 1,9 miliardi di dollari di finanziamenti per progetti di conservazione in un arco di 25 anni. Il risultato è stato allarmante: oltre l’80% di quei fondi è stato assegnato a vertebrati, con una netta preferenza per mammiferi di grande taglia come elefanti e rinoceronti. Anfibi, funghi e alghe hanno ricevuto un’attenzione marginale, nonostante la loro elevata vulnerabilità.
Come evidenziato da Benoit Guénard, uno degli autori, l’intero budget globale per la conservazione in quei 25 anni rappresentava meno dell’1% del bilancio militare annuale degli Stati Uniti.
Manipolare la percezione pubblica: strategie di comunicazione visiva
Alcuni ricercatori hanno cercato di contrastare il pregiudizio visivo manipolando le immagini di animali trascurati, rendendoli esteticamente più “appetibili” con occhi grandi, espressioni docili e pose carine. I risultati hanno mostrato che gli animali “abbelliti” ricevevano in media 640 dollari in più in donazioni rispetto alle versioni originali.
Organizzazioni come la Ugly Animal Preservation Society, fondata dal comico britannico Simon Watt, cercano da anni di portare all’attenzione pubblica specie come il pesce blob o la scimmia dal naso a proboscide, evidenziando che la conservazione non dovrebbe basarsi sull’estetica.
Ridefinire la “tenerezza” per salvare l’invisibile
Alcune istituzioni come l’Oregon Zoo hanno lanciato campagne per ridefinire il concetto di fascino, presentando fianco a fianco animali come il panda rosso e la lampreda del Pacifico dai denti aguzzi. Il messaggio è chiaro: ogni specie ha un ruolo cruciale negli ecosistemi, anche quelle che non sono fotogeniche.
Ribilanciare la narrativa globale
Secondo Alice Hughes, co-autrice dello studio di febbraio, è urgente riformulare la percezione pubblica e redistribuire equamente i fondi tra tutti i gruppi tassonomici. Solo così sarà possibile invertire il declino della biodiversità e garantire un futuro anche alle specie più silenziose, meno colorate ma ecologicamente indispensabili.
(Fonte: ScienceNews.org)