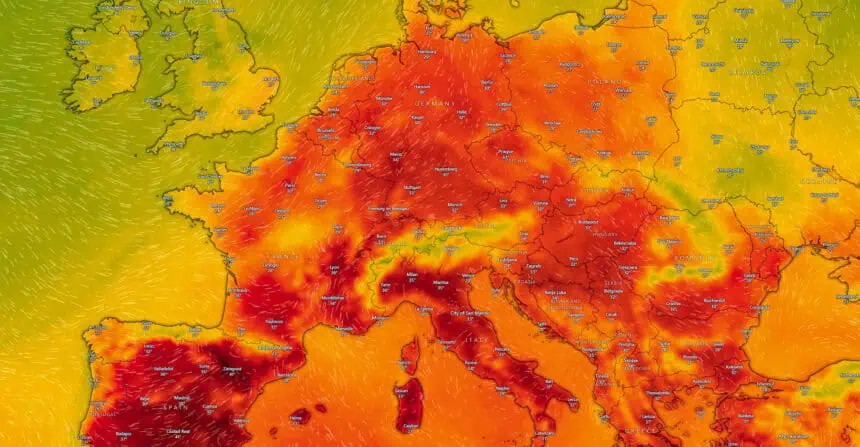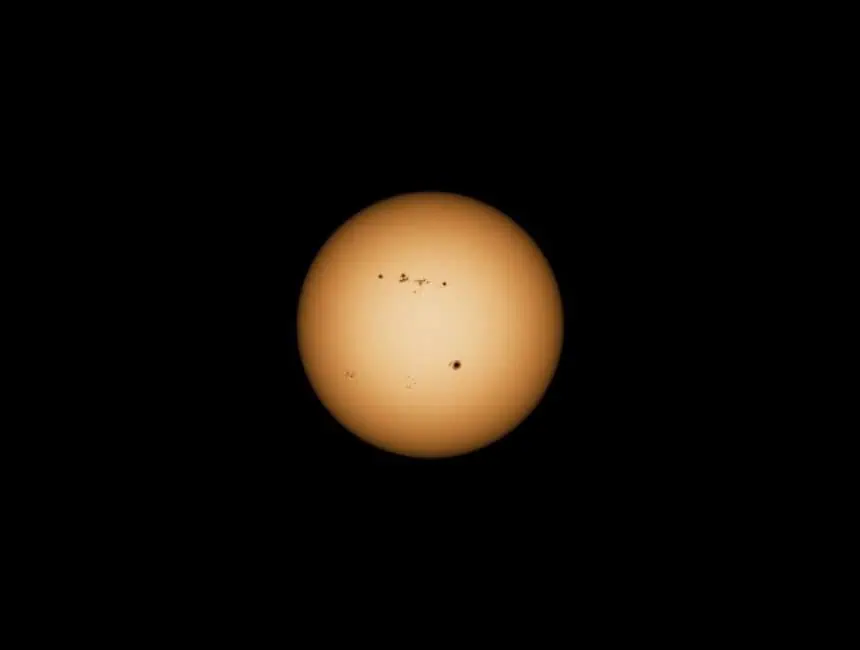La sofisticazione della tecnica Levallois rivaluta l’ingegno neanderthaliano
Un’innovativa ricerca dell’Università di Wollongong ha scosso le certezze sulla presunta inferiorità tecnica dei Neanderthal, rivelando che questi antichi artigiani possedevano abilità cognitive e manuali di gran lunga superiori a quanto ipotizzato. Il cuore della scoperta è legato al metodo Levallois, una raffinata tecnica di scheggiatura della pietra utilizzata tra 200.000 e 400.000 anni fa.
Questa tecnologia prevedeva la modellazione precisa di un nucleo litico, che veniva sagomato secondo una forma tipica – spesso simile a un guscio di tartaruga – per poi permettere il distacco controllato di schegge affilate, già pronte all’uso come coltelli, raschiatoi o punte da caccia. Una procedura che esigeva non solo coordinazione motoria, ma anche pianificazione strategica, memoria a lungo termine e capacità astrattiva.
Dall’archeologia sperimentale alla rivoluzione interpretativa
Tradizionalmente, la comunità scientifica ha considerato i risultati della tecnica Levallois come largamente determinati dalla forma iniziale del nucleo. In altre parole, una cattiva preparazione comprometteva l’esito, lasciando poco margine d’azione durante la fase di colpo. Tuttavia, i ricercatori australiani hanno decostruito questa convinzione utilizzando repliche in vetro calce-soda stampate in 3D, basate su autentici nuclei Levallois rinvenuti in scavi archeologici.
Questa scelta ha permesso di standardizzare la forma e le caratteristiche della pietra, concentrando l’attenzione sul vero protagonista del processo: l’angolo d’impatto del colpo.
L’angolo che cambia tutto: la precisione dei colpi dei Neanderthal
I risultati sperimentali hanno dimostrato che variare l’angolazione con cui si colpisce il nucleo Levallois influisce drasticamente sulle caratteristiche delle schegge prodotte. Colpi più perpendicolari – con angoli più bassi – generano schegge più grandi, pesanti e funzionalmente migliori, rispetto a quelli sferrati con inclinazioni più oblique.
Questo implica che i Neanderthal non erano meri esecutori passivi, ma piuttosto artigiani capaci di modulare con intelligenza i gesti in funzione del risultato desiderato. Un controllo così preciso del gesto manuale lascia intravedere una cultura del fare complessa, forse basata su insegnamento attivo, trasmissione orale di tecniche e persino strutture linguistiche.
Una nuova lettura degli artefatti Levallois
I dati dello studio offrono anche una spiegazione plausibile a un’osservazione fatta da tempo: le cosiddette schegge preferenziali, più uniformi e con angoli smussati, erano sempre state un mistero. Ora è evidente che l’angolo del colpo può essere la chiave per comprendere questa regolarità morfologica. È un’ulteriore conferma che i Neanderthal pianificavano in modo preciso le loro azioni e adattavano le tecniche a seconda del tipo di strumento richiesto.
La rivalutazione del pensiero neanderthaliano
L’insieme di questi dati ribalta il paradigma: non solo i Neanderthal possedevano competenze tecniche avanzate, ma potrebbero aver avuto anche forme di comunicazione articolata e una capacità di trasmissione culturale sorprendentemente simile a quella delle prime comunità Homo sapiens. L’antropologia cognitiva e l’archeologia sperimentale aprono ora nuove strade per indagare le origini della cultura materiale e dell’intelligenza simbolica.
Lo studio completo è stato pubblicato sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences.