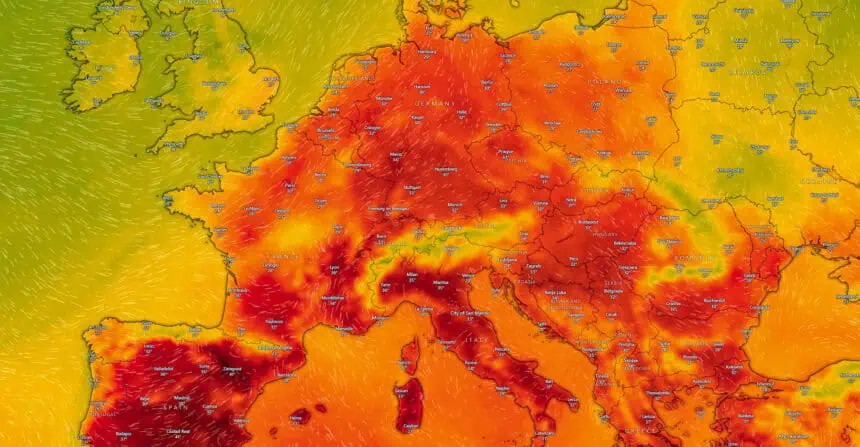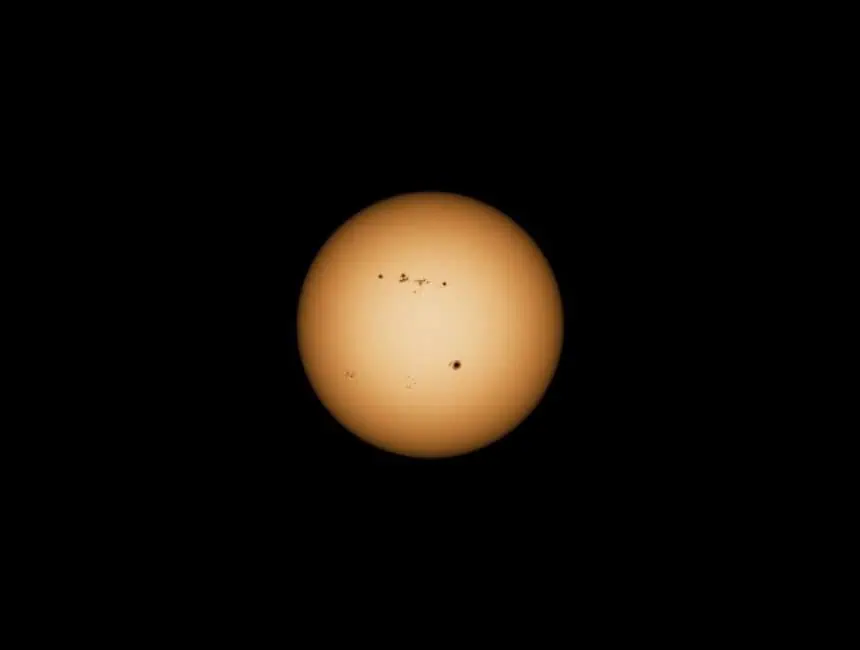L’adolescente salvato dal diabete che cambiò la storia della medicina
Nel Gennaio del 1922, in un reparto ospedaliero di Toronto, un ragazzo di nome Leonard Thompson, affetto da diabete mellito, si trovava in condizioni disperate. All’epoca, la diagnosi di diabete, soprattutto nei giovani, rappresentava una condanna a morte: non esistevano trattamenti efficaci, e l’unica soluzione proposta era una dieta ipocalorica tanto drastica quanto inefficace, che spesso portava i pazienti a una debilitazione estrema. Thompson pesava solo 29,5 chilogrammi. Quando i medici gli somministrarono una nuova sostanza sperimentale, chiamata insulina, avvenne il miracolo: in poche ore, i suoi livelli di glucosio si normalizzarono. Era nato uno dei farmaci salvavita più importanti del XX secolo.
Un’idea, un laboratorio e un esperimento con i cani
L’insulina non emerse dal nulla. Già dalla fine dell’Ottocento, si sapeva che il pancreas giocava un ruolo cruciale nella regolazione della glicemia. Fu il medico canadese Frederick Banting, docente presso l’Università di Toronto, a voler indagare più a fondo sulle “sostanze pancreatiche”. Nel Maggio del 1921, ottenne l’appoggio dello scienziato John Macleod, che gli mise a disposizione laboratorio e personale, tra cui lo studente Charles Best.
Banting e Best iniziarono le loro ricerche asportando il pancreas ai cani, per poi somministrare loro un estratto pancreatico grezzo. I risultati furono promettenti: il glucosio nel sangue diminuiva. Alla fine dello stesso anno, si unì al team anche James Bertram Collip, con il compito specifico di purificare l’estratto per renderlo adatto all’uso umano. Questo passaggio fu decisivo per arrivare alla prima somministrazione a Thompson.
Dal laboratorio al mercato: il ruolo decisivo di Macleod
Nonostante Banting fosse l’autore dell’idea iniziale, fu Macleod a garantire che il progetto si traducesse in un vero farmaco. Grazie alle sue connessioni accademiche e industriali, riuscì a brevettare l’insulina e a stabilire una collaborazione strategica con la casa farmaceutica Eli Lilly, che iniziò la produzione su larga scala di insulina di origine animale, estratta da mucche e maiali.
Questa formulazione permise di salvare milioni di vite, ma aveva limiti evidenti: provocava reazioni allergiche, richiedeva più iniezioni giornaliere ed era soggetta a problemi di approvvigionamento. Nel 1936, Novo Nordisk introdusse una versione a rilascio lento, migliorando l’efficacia e la distribuzione. La vera rivoluzione arrivò però solo negli anni Ottanta, quando Eli Lilly riuscì a sintetizzare l’insulina umana in laboratorio utilizzando batteri geneticamente modificati di Escherichia coli, segnando l’inizio della moderna biotecnologia farmaceutica.
Una scoperta contesa: il Nobel e la rottura tra scienziati
Nel 1923, il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina fu assegnato a Frederick Banting e John Macleod. Ma la scelta del comitato fu tutt’altro che pacifica. Banting era furioso: riteneva che il merito dovesse essere condiviso con Charles Best, il suo giovane collaboratore. Macleod, invece, riteneva fondamentale l’apporto del biochimico Collip.
In un gesto simbolico, Banting divise il premio in denaro con Best, e Macleod fece lo stesso con Collip. Tuttavia, la frattura tra i due principali vincitori non si rimarginò mai: Macleod tornò in Scozia nel 1928 e morì nel 1935, mentre Banting perse la vita in un incidente aereo nel 1941.
Il diabete oggi: numeri e sfide contemporanee
Oggi, negli Stati Uniti, ci sono oltre due milioni di persone con diabete di tipo I, di cui più di 300.000 sono bambini e adolescenti. La differenza con il passato è abissale: mentre nel 1920 circa il 66% dei bambini moriva entro poco più di un anno dalla diagnosi, oggi il diabete è una condizione cronica gestibile grazie all’insulina sintetica e ai moderni strumenti di monitoraggio glicemico.
Scienza, rivalità e progresso: una storia umana dietro la medicina
Come sottolinea Hall, storico della scienza, è essenziale non dimenticare la complessità che accompagna ogni grande scoperta. I racconti eroici spesso semplificano eccessivamente processi che sono in realtà ricchi di errori, tensioni e collaborazioni forzate. Ma proprio in questa complessità risiede la vera ricchezza della scienza: nella sua capacità di evolversi, anche attraverso conflitti, verso l’obiettivo comune del progresso umano.
Fonte: The Nobel Prize Organization – The discovery of insulin
Fonte: American Diabetes Association – Statistics