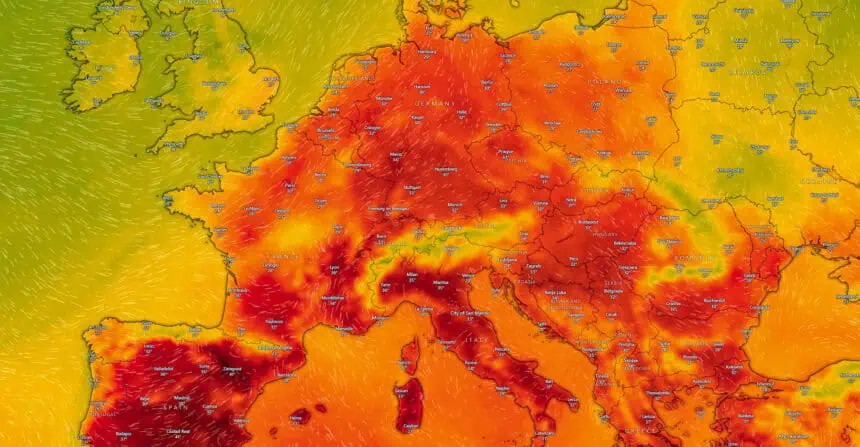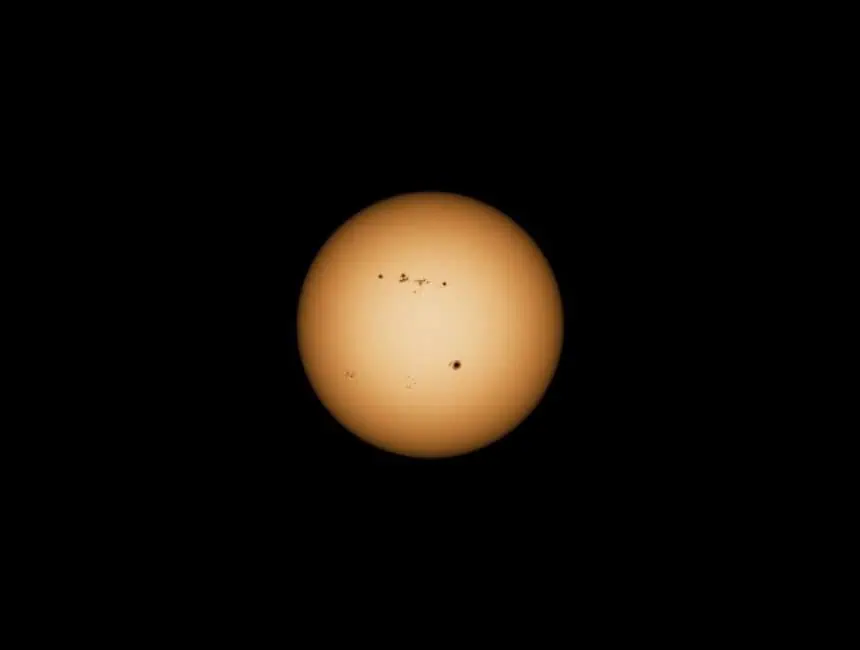Il significato di una scoperta scientifica “statisticamente significativa”
Nel linguaggio della scienza moderna, una scoperta viene considerata “reale” quando supera determinati criteri matematici, spesso espressi in termini di significatività statistica. Una delle soglie più celebri in fisica e in altre scienze sperimentali è quella del “5 sigma”, ovvero una probabilità di errore inferiore a circa 1 su 3,5 milioni. Se un risultato supera questa soglia, è considerato molto improbabile che sia dovuto al caso.
Tuttavia, questa certezza numerica è più fragile di quanto sembri. Gli strumenti statistici usati per dimostrare l’affidabilità di una scoperta si basano su modelli matematici che, pur sofisticati, richiedono assunzioni semplificative, spesso distanti dalla complessità del mondo reale.
Il ruolo (spesso frainteso) del “p valore”
Uno degli strumenti più utilizzati è il cosiddetto “p-value”, che misura la probabilità di ottenere un risultato uguale o più estremo di quello osservato, se l’ipotesi nulla fosse vera. Ma un valore basso di “p” non implica automaticamente che l’ipotesi sia falsa: indica solo che il risultato osservato sarebbe molto raro in un determinato contesto teorico.
Molti studiosi hanno criticato l’abuso e l’eccessiva fiducia riposta nel p-value. Alcuni ricercatori, infatti, modificano o selezionano i dati in modo da ottenere artificialmente una significatività statistica, una pratica conosciuta come “p-hacking”. Questo approccio può portare a falsi positivi e a risultati che non sono realmente riproducibili.
Il mito del 5 sigma e il caso dell’LHC
Un caso emblematico è quello del Large Hadron Collider (LHC) presso il CERN di Ginevra, dove nel 2012 è stata annunciata la scoperta del bosone di Higgs. Il team ha atteso di raggiungere la soglia dei 5 sigma prima di annunciare pubblicamente il risultato. Ciò corrisponde a una probabilità di errore inferiore a 0,000057%, una misura che vuole garantire una robusta affidabilità.
Ma anche in questo caso, si tratta di un livello di fiducia legato a un particolare modello statistico e a ipotesi specifiche sui dati di partenza. In altre parole, anche una scoperta a 5 sigma non è immune da errori sistematici o da interpretazioni scorrette.
La matematica come linguaggio, non come oracolo
La frase provocatoria dello scrittore Terry Pratchett, secondo cui le probabilità di uno su un milione si verificano “nove volte su dieci”, sembra un paradosso. Tuttavia, nel contesto narrativo dei suoi romanzi fantasy, assume un significato profondo: quando gli eventi sono guidati da storie, emozioni e destino, la matematica non ha l’ultima parola. È un modo per ricordare che, anche nella realtà scientifica, i numeri non vivono nel vuoto: sono interpretati da esseri umani, soggetti a bias cognitivi, desideri e convinzioni.
La matematica, in questo senso, non è un giudice assoluto, ma un linguaggio potentissimo che ci aiuta a formulare ipotesi, a testarle e a valutarle. Ma proprio come ogni linguaggio, può essere usato in modo onesto o distorto. Ed è qui che entra in gioco il senso critico della comunità scientifica.