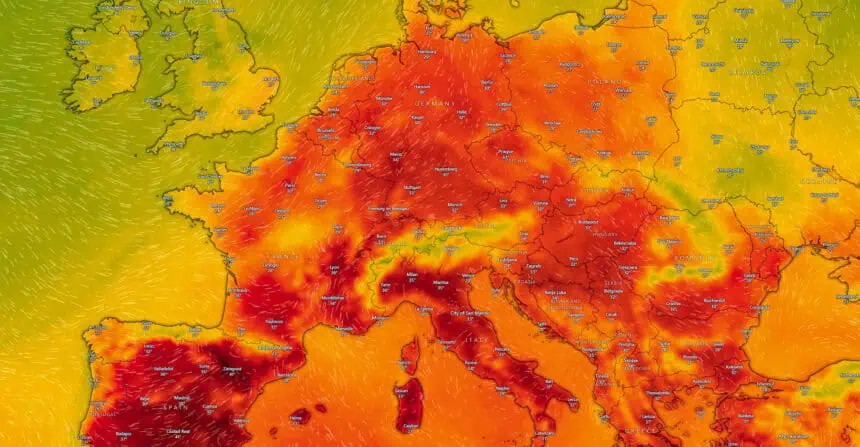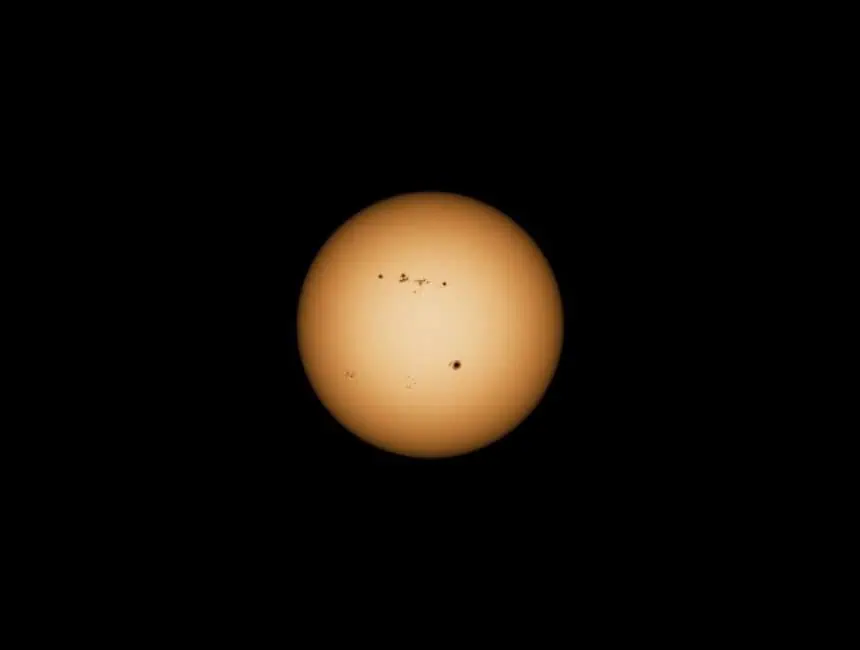Un’antica meraviglia tra ombra e splendore
Nel cuore dell’Acropoli di Atene, il Partenone, simbolo intramontabile della cultura greca classica, cela ancora oggi misteri affascinanti. Tra questi, uno dei più profondi riguarda l’esperienza sensoriale e spirituale che l’ambiente interno del tempio era in grado di suscitare. Nonostante sia ormai un rudere, un tempo questo tempio maestoso racchiudeva una delle opere più celebrate dell’antichità: la statua di Atena Parthenos, creata dallo scultore Fidia nel 438 a.C., scolpita in avorio e oro.
Oggi, una nuova ricerca dell’Università di Oxford guidata da Juan de Lara ha gettato nuova luce – letteralmente – su come la combinazione tra luce e oscurità contribuiva a rendere sacro questo spazio.
La simulazione ottica del divino
Attraverso ricostruzioni 3D ad alta precisione e modelli fisici di propagazione della luce, de Lara ha indagato come la luce naturale interagisse con la struttura interna del Partenone, rivelando una coreografia luminosa progettata con precisione. Il team ha impiegato software che tengono conto dell’angolazione del sole nel V secolo a.C., della riflettanza dei materiali e della disposizione architettonica dell’edificio.
Il risultato? L’interno del tempio era intenzionalmente oscuro, ma in momenti specifici dell’anno – in particolare durante il Festival Panatenaico – la luce del sole penetrava attraverso la porta principale, colpendo con precisione il corpo dorato della statua della dea. Questo fenomeno non era casuale: era un rituale visivo concepito per evocare il soprannaturale.
Illuminazione e spiritualità nell’antichità greca
Contrariamente all’immaginario ottocentesco che vedeva i templi greci come spazi bianchi, razionali e luminosi, il nuovo studio restituisce un’immagine più autentica e sensoriale del Partenone. Gli interni erano ambienti oscuri, saturi di incenso, suoni e oggetti sacri, dove la luce diventava un elemento teatrale, quasi cinematografico.
La statua della dea non era sempre visibile. Al contrario, emergeva dal buio in particolari condizioni, accentuando il senso di timore reverenziale che i visitatori provavano varcando la soglia del tempio.
Luce e architettura come linguaggio sacro
Secondo de Lara, la combinazione tra oscurità e luce non era solo una necessità architettonica, ma una scelta artistica e spirituale. Le superfici in marmo lucidato, le bacinelle d’acqua disposte all’interno, e la posizione strategica del tempio creavano una sorta di “effetto speciale” con cui il culto veniva esaltato. “Stavano lavorando con effetti speciali,” ha dichiarato de Lara, facendo riferimento alla sapienza tecnica degli architetti dell’epoca.
Un’eredità culturale e scientifica
Il progetto rappresenta una pietra miliare per l’archeologia sperimentale, utilizzando la tecnologia non solo come strumento illustrativo, ma come mezzo analitico per scoprire nuove verità. Le simulazioni offrono una comprensione più profonda dell’interazione tra architettura, religione e percezione sensoriale nella Grecia antica.
Questo lavoro, pubblicato nell’Annual of the British School at Athens, ridefinisce l’esperienza del Partenone, offrendo una visione che arricchisce anche l’esperienza contemporanea del monumento, visitato da oltre 3 milioni di persone ogni anno. Come conclude de Lara, restituire al pubblico una visione più autentica e coinvolgente del Partenone può trasformare una visita da semplice osservazione a esperienza di connessione con il passato.
(Maggiori dettagli sullo studio sono disponibili nell’articolo originale di IFLScience: IFLScience – The Parthenon’s Sacred Light).